APPUNTI
E SPUNTI
ANTICA
FONTANA DI GALLIPOLI
di
Elio Pindinelli
Lungi dall’essere stato compiuto e pubblicato.un esauriente studio sulla fontana antica di Gallipoli che universalmente ne facesse accettare datazione e vicende costruttive, col passare degli anni anche tra gli studiosi di storia nostrana e tra gli specialisti, nell’alternarsi di riaffermate certezze e di cauti ripensamenti, andavano invece delineandosi contrapposte tesi e discordanti pareri, dei quali 2 sembrano oggi prevalenti su tutti:
Il primo di chi, perpetuando una memoria ed una denominazione storicizzata nel tempo, ne riporta le origini ad un’età ellenistica, al periodo imperiale romano cioè; Il secondo di chi esasperando al contrario ogni critica ed analisi ne data al 1560 il concepimento e la costruzione, nello spirito rinascimentale del recupero di canoni e di stilemi cari al mondo classico.
Chi scrive non ha mai accettato nessuna di queste due contrapposte tesi pur avendo severamente protestato in tempi recenti per l’acritico pronunciamentO della Sopraintendenza ai Monumenti 1, la quale aveva ritenuto esaurienti e compiuti giudizio e datazione sentenziati nel lontanto 1912 dall’arch. Bemich. 2
Sono convinto infatti che la semplice analisi stilistica del monumento giammai riuscirebbe a placare il profondo desiderio che il Gallipoli-no ha di capire e comunque di pretendere esaurientemente motivato ogni parere che volesse tentare di mettere in discussione secolari convinzioni che appartengono ormai alla cultura ed alla storia della Città.
Preliminari,
perciò, ad auspicati successivi interventi e contributi potranno essere
considerati questi miei appunti sull’argomento e le conseguenti personali
ipotesi che vanno senz’altro verificate alla luce di probanti documenti,
ma che ritengo valide per un metodo di lavoro finalizzato a comprendere
gli avvenimenti della storia, di cui molto spesso il monumento non resta
che il muto solitario testimone, quale appunto è oggi la fontana di Gallipoli.
 |
Nell’Ottobre del 1673, narra una pagina del manoscritto Roccio trascritta dal parroco Occhilupo ~, vedendosi mancare l’acqua alla fontana pubblica, il governo della Università gallipolina comandò si perlustrassero i condotti dell’acquedotto per svelarne le cause.
Percorse
le sotterranee canalizzazioni senza alcun esito positivo i mastri giunti
al primo pozzo di alimentazione dell’acquedotto praticato ai piedi delle
balze dei Cappuccini, verso scirocco, vi scorsero incise sulla pietra
di chiusura della bocca del pozzo stesso e sulla nuda roccia circostante
una lunga serie di iscrizioni le quali con cura l’Occhilupo ebbe cura
di trascrivere e che qui io ora fedelmente riproduco:
Stefano Scalfone 1000
1560
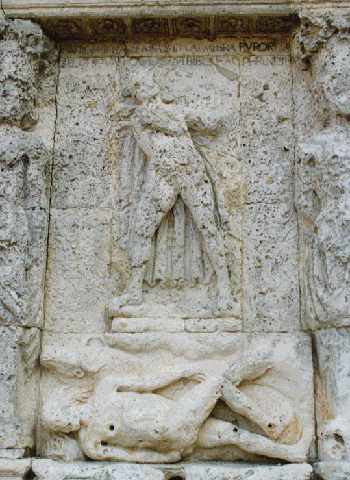 |
Antiopae rabiae mea stillant membra furorem Zelotipum causas, qui bibis hanc frenesim
 |
Salmaces optato nimpha marito
Felix virgo sibi si scit inesse virum
Et tu formosae iuvenis permiste puellae
 |
Biblis amara vocor dulces tu sugge mammillas
Innanzitutto le immediate considerazioni.
I testi dei tre distici sostanzialmente, tranne qualche variante, concordano con quelli rilevabili ancora oggi sul fronte della fontana meno l’intestazione in Aerumnae del terzo a differenza dell’accreditata Erubescentiae, che comunque solleticano un qualche confronto critico.
Importante
poi sembra la presenza del nome di un personaggio, Stefano Scalfone, che
io suppongo sia stato l’ingegnere idraulico che nel 1560 dovette affrontare
e risolvere il problema della rinnovazione dei condotti e dei pozzi di
alimentazione dell’acquedotto della fontana in concomitanza con lo spostamento
di questa dal sito prossimo alla antica chiesa di S. Nicola, cui era stata
collocata nel 1548, se dobbiamo dare fede a quanto annota il Micetti ‘~ a p. 385 del suo manoscritto: “d’ordine del medesimo (Ferrante Loffredo)fu
trasportata dalli Corici la fontana vicino S. Nicola, che fu nel 1548”.
E’
indubbio che un acquedotto, molto probabilmente di età romana, alimentato
secondo il sistema dei Qanat noto presso i popoli orientali prima
ancora che Vitruvio ne dettasse le caratteristiche nel De Architectura, esistesse in Gallipoli
nel tempi remoti, e neI sopravvivono le reliquie ancor oggi in località
“Fontanelle”, con una serie di condotti sotterranei che dovevano giungere
sino alle porte della Città se il Galateo
ne aveva rilevato i ruderi agli inizi del ‘500.
Certamente l’impianto di una fontana nel 1548 nei pressi della chiesetta di S. Nicola aveva comportato il rifacimento o il restauro dell’antico acquedotto fin dai “Corici”, ove sboccava il lungo condotto sotterraneo a tunnel attraverso cui scorrevano le acque captate per per-colazione e per il convogliamento delle sorgive di più pozzi collegati tra di loro in località “S.Leonardo” 6
Stefano Scalfone che ritrovo presente in Gallipoli dal 1549 al 1551 7 dove essere stato il restauratore di tale acquedotto o l’artefice del nuovo nel 1560; ad eccezione che il numero 1000 inciso al di sotto del nome non sia riferibile in qualche modo alla distanza del pozzo dalla porta di Città il che farebbe ipotizzare invece, per il chiaro riferimento ai “mille passus e continentia aedificia” di età romana, alla esistenza in quell’epoca di una magistratura civica che ampliava la sua influenza al di fuori del pomenio urbano quale a me sembrerebbe necessario per invigilare contro eventuali inquinamenti della zona deputata ad alimentare la fontana.
In
qual caso si dovrebbe vedere in Stefano Scalfone un vero e proprio deputato
alle acque.
Ma su tale argomento, se mi sarà data la possibilità mi piacerà ritornare in altra occasione.
Dall’esame del testo trascritto dall’Occhilupo un’altra considerazione poi a me sembra oltremodo evidente, come cioè le tre parole latine UNA EADEM DIVERSA, che confermano oltretutto l’esatta interpretazione fatta nel lontano 1924 da Paolo Wolters 8 nel corso di una conferenza tenuta presso l’Associazione scientifica d’arte in Monaco della lunga serie di lettere leggibili (ora un pò meno) sull’architrave del monumento gallipolino, da molti in precedenza definita oscura tanto da rifenirla ad una sorta di memoria circa l’erezione della fontana, partorita la prima volta dalla fantasia fervida di Giuseppe Massa 9 e puntualmente ripresa anche ai giorni nostri, assumono alla luce della loro collocazione ognuna accanto a ciascun distico, una chiara funzione esplicativa del concetto di base che dovette animare l’artefice e della nuova canalizzazione idrica e del complesso architettonico per come oggi è conosciuto.
Così come, cioè, l’acqua, captata attraverso lo scavo di alcuni pozzi e incanalata per condotti sotterranei per varie vie giunge al suo estremo, anche la passione amorosa, che si placa e si nobilita nel matrimonio (Amor), può giungere agli opposti se la si lascia correre negli alvei della gelosia (=Zelotipum) o dell’incesto (Aerumnae=il sinistro caso).
E a quali personaggi della mitologia classica fare ricorso per rendere più efficacemente questa lezione se non a Dirce, devastata da unto-no a causa della vendetta di Anfione e Zeto; se non a Bibli la ragazza che anse di insana passione per l’amato fratello; se non infine alla giovane Salmace che accesa d’amore per il bel fanciullo, figliolo di Venere e Mercurio, ottenne dagli dei che in un sol corpo fossero ricordati gli attributi dei due esseri?
Dirce, Salmace e Bibli, 3 ninfe che nella tradizione classica furono trasformate in fonti dagli dei pietosi, avevano meritato quindi il destino di ammonire i vizi e di esaltare l’amore in una sostanziale unità concettuale ed espressiva, cui giustamente si era richiamato Paolo Wolters, in un chiaro intento moralistico, sociale-politico-didattico, chiaramente per niente attribuibile ad età antica o classica.
Sia pure con tutte le possibili cautele e salvi eventuali necessari nscontri e conferme, infatti, sono convinto che la fontana di Gallipoli non può essere stata concepita che sulla spinta di motivazioni ideologico-culturali scaturite in un contesto politico-sociale particolarissimo e ispirate in qualche modo dal potere politico centrale.
E per comprendere ciò occorre per un attimo rileggere in filigrana i fatti storici avvenuti nel tempo in cui presumibilmente maturò il progetto della costruzione del monumento.
Nel 1547 infatti (ad un anno dopo il Micetti data lo spostamento dai Corici della fontana) scoppia a Napoli una grave sommossa popolare che mette in pericolo la stessa vita del Viceré don Pietro de Toledo a motivo che questi aveva tentato di introdurre l’inquisizione all’uso spagnolo.
Non è questa la prima volta, e non sarà l’ultima, che si tenta di portare a compimento un tale disegno politico.
Già nel 1509 un’altro Viceré, il Conte di Ripacorsa, ricorrendo anche al pretesto della ricevuta denuncia secondo cui in Puglia e Calabria nefande orge avvenivano durante le quali “usavano li padri con le figlie et altri con le sorelle” 10 aveva tentato l’impresa senza però alcun risultato pratico.
In quel 1547, mentre tutta Napoli è in rivolta confortata dall’adesione di numerose Province del Regno, l’Università di Gallipoli invece è apertamente alleata con le scelte politiche centrali e avanza addirittura l’offerta personale al Viceré de Toledo di inviare a Napoli 200 cittadini armati a difesa della sua persona 11•
E’ possibile che anche nel 1547 sia stato utilizzato il pretesto introdotto il 1509 dal Conte di Ripacorsa per giustificare il tentativo di introduzione dell’inquisizione nel Regno?
E a livello politico-sociale i fatti ivi denunciati, se reali e non inventati, trovavano ancora manifestazioni al 1547?
Potrebbero essere buone “ipotesi di lavoro” per arrivare a comprendere a pieno motivazione e linguaggio singolanissimi che caratterizzano il monumento gallipolino.
Sarebbe d’altronde superfluo, ritengo, sollecitare a questo punto l’attenzione del lettore sul significato profondo che l’artista deve aver voluto dare alla raffigurazione scultorea della favola di Salmace, che non a caso è centrale nell’opera: due corpi cioè distesi, cinti alla vita da un cordone sostenuto per le mani da un personaggio che non pare dubbio doversi riconoscere come la dea Venere, a suggello di una unione, propiziata da Cupido, che si intravede in alto a sinistra pronto a scoccare il dardo fatale, e benedetta dagli dei, da cui frutto di atto d’amore germinerà una prole, maschio o femmina che sia, che per l’antico eterno mistero della vita, rinnoverà, proprio come Salmace aveva chiesto agli dei, nelle proprie carni le fattezze e gli attributi dei genitori.
Ma dunque, monumento concepito e costruito nel ‘500 la fontana di Gallipoli?
Se posta semplicisticamente in questi termini la risposta non potrebbe che essere una possibile, se non fosse per una infinità di piccoli dubbi e di contrastanti risposte a numerosi riscontri quali per esempio:
- Le figurazioni presenti lungo l’architrave e niproducenti scene tratte dalle fatiche di Ercole, difficilmente riconducibili a quella sostanziale unità interpretativa manifestantesi tra distici e raffigurazioni mitologiche;
- L’uso di più materiali nell’assemblaggio dell’opera che diventa sintomatioo e rivelatore di più momenti di esecuzione se accoppiato al fatto che le figurazioni alte presentano una sorta di ornato a fogliame del tutto assente in quelle basse scolpite invece in un calcare più compatto e di un colore più bianco;
- Le vasche più raffinate nel gusto e impreziosite da graziosi puttini e da ghirlande, che appena si scorgono rose dal tempo edace, e tanto differenti e lontane per bellezza ed esecuzione tecnica dalle restanti parti;-
- Il passo, infine, già citato del manoscritto del Micetti, con l’assillante quesito se debba realmente leggersi nel senso che un relitto di antico monumento, già esistente ai Corici, fu effettivamente trasportato e ricomposto l’anno 1548 nelle vicinanze della Chiesa di S. Nicola.
Tutti dubbi alimentati ed avvalorati da una semplice osservazione che mi sono sorpreso a fare non molto tempo addietro, scaturita senza nessuna forzatura, con naturalezza stupito quasi che altri mai l’abbia potuta rilevare.
Se le figurazioni infatti riferite a Salmace e a Bibli in un certo qual modo esprimono compiutamente il concetto che sta alla base della loro realizzazione potendosi senza molto sforzo ai loro miti riferire ogni personaggio e particolare scolpito nella pietra, per la raffigurazione di Dirce invece contrastata e poco convincente appare la identificazione con Bacco (come ipotizza alcuno) o con Anfione del personaggio che appare in posizione eretta e frontale nella parte alta del comparto, in una non ben definita movenza di braccia, mentre il personaggio femminile che nella parte bassa appare contornato da 2 tori è stato identificato da tutti in base al relativo distico come Dirce moglie di Lico re di Tebe.
Non trovo per quanto abbia cercato e nelle fonti classiche e nelle raffigurazioni anche di epoche successive riferimenti a Dirce che non indicassero sempre per il suo supplizio un sol toro o un sol cavallo (ed è variante molto tarda).
Perchè allora nel monumento gallipolino le presenze sono raddoppiate, mutuate da quale letteratura o da quale tradizione?
Invano, io credo, si cercherebbe una qualche risposta se si volesse insistere sul personaggio di Dirce.
Narra invece un altro ben più famoso mito greco, e qui mi sono di supporto reminiscenze scolastiche non mai sopite, che Pasifae figlia del Sole, anse di passione per un bellissimo toro bianco e non sapendo come riuscire a possederlo si rivolse a Dedalo, il famoso architetto, il quale concepì di costruire una bellissima vacca di legno, che ricoprì di pelle per farla sembrare vera, e consigliò la regina di introdurvi-si dentro, le gambe nel cavo delle zampe posteriori del finto animale.
Il consiglio di Dedalo fu subito eseguito da Pasifae che ordinò di portare nel campo in cui pascolava il bianco toro, lo strumento del progettato inganno.
A credere alla storia sembrerebbe che non fu difficile a Pasifae attirare il focoso animale bianco e consumare il meditato amplesso, il cui frutto generato fu il mitico Minotauro dal corpo di uomo e dalla testa di toro.
Pasifae dunque non Dirce il personaggio ed il mito raffigurato nel primo comparto della fontana di Gallipoli, e il lettore facilmente se ne convincerà osservando attentamente la riproduzione fotografica del particolare che qui si pubblica, che si lega in qualche modo con la storia di Ercole della trabeazione e che apre sull’origine di questo singolare monumento a nuove prospettive di interpretazione e di datazione.
Mi sembra possibile con tali presupposti infatti ipotizzare che elementi di un monumento più antico siano stati utilizzati in una nuova espressione e concettualità attribuendo a figurazioni antiche riferimenti a miti di cui si era nel tempo perduta ogni memoria storica e tradizionale.
1) E. Pindinelli, Per
quali fini la fontane è diventata
«rinascimentale», in: «La Gazzetta
2) E. Bernich, Spigolature
artistiche. 1. Lo fontana di Gallipoli, in Apulia, a. II. fasc.III.1V,
1911, pagg. 225-228.
3) A. Roccio, Memoria
dell’antichità della Città di Gallipoli, Ms. n. 76 della Biblioteca
Provinciale di Lecce, fol. 567-570.
4) L. A. Micetti, Memorie
storiche della Città di Gallipoli, Ms. n. 347 della Biblioteca Provinciale
di Lecce.
5) A. Galateo, Callipolis descriptio, Basilea,
1558.
6) M. I. C. A. Servizio
geologico d’Italia. Note
illustrative della carta geologica d’Italia, foglio 214, Gallipoli Ercolano,
1969, p. 57.
7) Archivio parrocchia S. Agata - Gallipoli, Atti battesimali: A. 1549, 4 giugno, Stefano
Scalfone è compare al battesimo di Giacomo Delidano; A. 1549, 10 ottobre: al battesimo di Angelo Colopazo; A. 1550, 10 luglio, 6: al battesimo di
Porzia Lachibari; A. 1551, 1 agosto:al
battesimo di Lucrezia Lombardo.
8) P. Wolter, Werichte - Sitzungen der Kunstwissnsch afilichen gesellschafi
in Munchen - Sitzung am 10 Januar
1924. s.n.t.
9) G. Massa, Memoria
sulla fontana di Gallipoli - in fondo Briganti - Staiano - Cfr. A.
Mangione, Castiglione, Lecce
1986, p. 66.
10)
G. Coniglio,
I viceré spagnuoli di Napoli, Napoli,
Fiorentino 1967, p. 21 - Cita il ms. 754 della Biblioteca Nazionale di
Madrid.
11)
L. A. Micetti,
,Ms. citato, fol. 386; A. Roccio,
ms. citato, fol. 51.