I frantoi ipogei ed il commercio dell'olio in Gallipoli


Frantoio
ipogeo di Palazzo Granafei
Frantoio
ipogeo di palazzo Granafei
1)
Fin dal XVI secolo Gallipoli nell'ambito del commercio dell'olio d'oliva
era ritenuta la maggiore piazza di esportazione del Regno di Napoli.
Al fine di stabilire un equo prezzo di mercato il Comune lasciava alla
libera contrattazione l'olio fino al 5 dicembre di ogni anna. Il giorno
successivo nella ricorrenza di S.Nicola sulla base delle contrattazioni
avvenute su 8.000 stare di olio(pari a 124 tonnellate e 736 Kg.) il
Comune stabiliva la voce, cioè il prezzo corrente di vendita, naturalmente
in ducati.
Questo
prezzo era indicativo per i prezzi che si stabilivano poi alla borsa
di Napoli e di Londra.
L'olio
di Gallipoli era molto richiesto dai mercati del regno e di tutta Europa
e aveva un prezzo maggiore di tutti gli altri olii tra cui quelli di
Bari e della Calabria.
Nella
Biblioteca comunale di Gallipoli è conservato un volume originale della
voce degli olii stabilita nel XVIII secolo.
2)L'olio
prodotto nel territorio di Gallipoli e della Provincia perveniva nella
città per essere commerciato e depositato in capaci cisterne scavate
nel tufo. Nei documenti catastali del 1809 sono registrate non meno
di 2000 cisterne di olio nel sottosuolo della città vecchia di capacità
variabile tra le 10 e le cento salme(155 quintali). L'olio veniva commerciato
con caratteristici ordini in derrate a cura ed interesse delle numerose
case commerciali residenti in Gallipoli, tra la A.Auverny, la Stevens,
la V.Starace e la G.Palmentola.
In
tali ordini il valore della salma nella misura detta di magazzino corrispondeva
a Kg.147,31.
3)Le
olive raccolte nel territorio di Gallipoli, che allora comprendeva anche
gli attuali Comuni di Sannicola e Alezio, pervenivano generalmente nel
centro storico di Gallipoli per essere molite nei numerosi frantoi sotterranei
scavati nel tufo.
I
registri catastali del 1809-1857 registrano la presenza in città di
35 frantoi. Due di questi interessanti ambienti sono stati recuperati
da oltre dieci anni a cura dell'Associazione Gallipoli Nostra che ha
curato anche la ricostruzione fedele delle attrezzature originarie di
macinazione e spremitura delle olive.
Indispensabile
per la produzione dell'olio era la vasca di macinazione con una pesante
macina verticale in pietra azionata da un cavallo o da un mulo. Per
rendere più agevole il lavoro la vasca subì nel tempo varie modifiche
prima con l'impianto di due macine più basse e successivamente con un
sistema a tre macine con assi differenziati in modo da consentire una
maggiore superficie di macinazione e pari alla somma degli spessori
delle tre macine.
4)Con
la macinatura si produceva la pasta di olive che veniva equamente distribuita
su speciali piattelli intrecciati in giunco o in fibra di cocco detti
fisculi. Di questi piattelli veniva montata una alta catasta ai piedi
di speciali torchi in legno azionati a mano e che avevano la funzione
di spremere tutto l'olio contenuto nella pasta delle olive.
I
torchi a due vitoni erano detti torchi alla calabrese ed avevano i lunghi
vitoni fissi ancorati sotto roccia su speciali plinti in pietra. La
pressione occorrente per la spremitura veniva sviluppata mediante l'avvitamento
contemporaneo e robusto delle due madreviti sul grande travone in legno,
sotto cui era collocata la catasta di fiscoli.Un altro modello di torchio
è quello detto alla toscana, con madrevite fissata sotto volta e vitone
unico mobile. La pressione veniva sviluppata mediante l'azione di un
robussto asse in legno infilato nella testata del vitone centrale.
5)Nell'evoluzione
delle tecniche di produzione dell'olio dalla fine dell'800 furono dismessi
gradualmente i torchi in legno che furono sostituiti da presse strutturalmente
molto simili a quest'ultimi per la presenza di un lungo vitone ruotante
in una testata con funzione di madrevite.La caratteristica principale
che differenzia le presse dai torchi consiste in un doppio fascione
in ferro che imbriglia le resistenze all'atto della spremitura. Tale
modifica strutturale consentiva l'impianto di spremitura in locali edificati
a piano stradale con il conseguente abbandono di strutture sotterranee
una volta necessarie per contrastare la spinta contro la volta scavata
dei torchi.
6)Uno
dei massimi studiosi dei sistemi di coltivazione degli ulivi e di produzione
dell'olio fu il gallipolino Giovanni Presta (1720-1797), medico e agronomo
che dedicò gran parte della sua vita alla sperimentazione.Di lui scrissero
con lode lo svizzero Salis Marschlins, gli inglesi Swimburne e Clarke
nonchè Galanti e Palmieri. Il suo primo saggio fu pubblicato in Napoli
nel 1786 e conteneva una memoria intorno a 11 saggi diversi di olii
offerti all'imperatrice di Russia Caterina II unitamente ad uno studio
sulla ragia, una infezione a cui erano soggetti gli ulivi.
7)Un
altro saggio pubblicato da Giovanni Presta riguarda 62 saggi diversi
di olii presentati nel 1788 al re di Napoli Ferdinando IV. Tali saggi
il Presta aveva amorevolmente prodotto nel proprio frantoio facendo
esperienza delle varietà di olive e dei periodi di raccolta.Nel saggio
figura anche un esame critico dell'antico frantoio d'epoca romana rinvenuto
a Stabia. Era questo un modo per agganciarsi alle esperienze degli antichi
per migliorare le tecniche di produzione.
8)L'opera
più importante del Presta, che gli diede onore e prestigio a livello
nazionale ed internazionale riguarda un approfondito studio sulla coltivazione
degli ulivi e sulle tecniche di produzione dell'olio, pubblicato a Napoli
nel 1794.
Con
questo importante lavoro Giovanni Presta dimostrò la necessità di rinnovare
i frantoi secondo sistemi moderni di costruzione consigliando la dismissione
dei trappeti sotterranei. Tenuto in gran conto dai suoi contemporanei,
il testo del Presta inaugurò il principio della sperimentazione in agricoltura
sulla scorta dei principi illuministici e sulla spinta del vasto movimento
naturalistico e fisiocratico del tempo.
9)Gran
parte dell'olio prodotto o depositato nelle cisterne veniva venduto
a Paesi esteri, i quali avevano rappresentanza in Gallipoli con propri
vice consolati. In Gallipoli si ebbero fino al 1923 i consolati esteri
di molte nazioni europee. Pietro Maisen, un Valtellinese che visse a
Gallipoli e che scrisse nel 1870 "Gallipoli e i suoi dintorni"
un volume di memorie storiche e di descrizione della città, annotò la
presenza in quell'anno di ben 12 vice consolati in rappresentanza rispettivamente
di Austria, Danimarca, Francia, Inghilterra, Impero Ottomano, Paesi
Bassi, Portogallo, Prussia, Russia, Spagna, Svezia e Norvegia, Turchia.
La
nomina dei Vice consoli avveniva per rilascio di patenti da parte del
Ministero degli esteri della nazione interessata convalidate dal Ministro
per gli Affari esteri italiano.
10)La
spedizione dell'olio commerciato con l'estero avveniva via mare con
imbarco dal porto. Prima però l'olio veniva trasportato a spalla con
otri di pelle fino alle pile regie di caricamento collocate nel luogo
in cui vi è attualmente il mercato del pesce al dettaglio. Vi era addetto
un gabelliere regio che con un'asta di bronzo graduata misurava, ai
fini del pagamento della tassa di esportazione,la quantità d'olio da
esportare. Dalle pile regie di caricamento l'olio veniva immesso in
botti di legno di castagno che opportunamente contrassegnate e numerate
venivano imbarcate sulle navi in attesa alla fonda.
Al
momento del caricamento veniva compilato un documento di imbarco che
con le formule di rito indicava il destinatario del carico e la quantità
dell'olio nonchè il numero, con il relativo contrassegno, delle botti
caricate.
11)Un
altro documento necessario per la navigazione era la cosiddetta Patente
di sanità, cioè un apposito certificato dal quale risultava che la nave
e l'equipaggio partivano dal porto di Gallipoli, città in cui non si
registravano malattie contagiose.
La
formula di rito era generalmente la seguente: Parte da questa illustrissima
e fedelissima città di Gallipoli, ove per la Dio grazia, di sua SS.
Madre, e dei SS.nostri Protettori si vive sani e senza sospetto di male
contaggioso, la barca nominata...per andare a...
Il
documento recava all'intestazione con lo stemma reale e l'emblema civico,
le immagini di S.Agata e di S.Rocco.
12)Le
raffigurazioni del porto di Gallipoli nel periodo di commercializzazione
dell'olio d'oliva con l'estero sono numerose ed attestate da magnifici
dipinti del '700 dei quali il più importante, di Filippo Hackerth è
conservato nel Museo di San Martino a Napoli. Ma non mancano importanti
testimonianze fotografiche anche dei primissimi anni del '900 quando
ancora si potevano vedere le banchine portuali stracolme di botti pronte
per l'imbarco, e le navi attraccate ai moli mentre i moderni vapori
stazionavano alla fonda nel bacino portuale. Queste immagini trasfuse
in migliaia di cartoline postali viaggiarono dalla fine dell'800 in
tutta Italia ed all'estero.

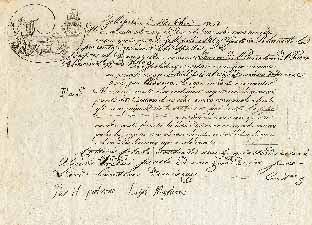
Frantoio
ipogeo di palazzo Briganti
Documento
d'imbarco dal porto di Gallipoli