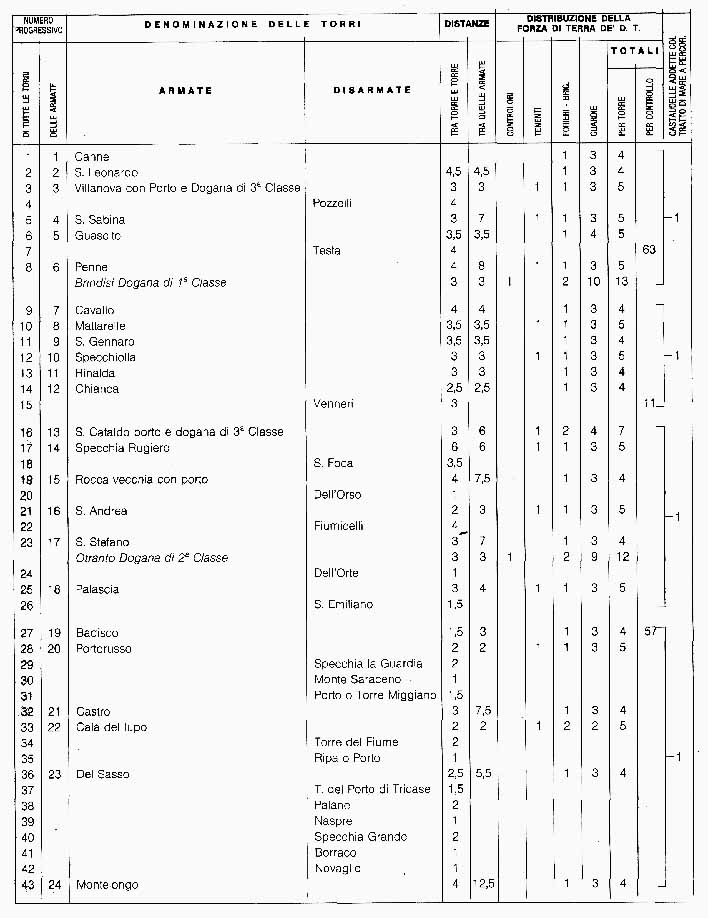Torri litoranee e controlli
Sempre
più intensa quanto proficua va dimostrandosi l’attività pubblicistica
e di ricerca finalizzata a tracciare una mappa la più completa possibile,
in termini di recupero della memoria storica e di salvaguardia ambientale
ed architettonica, di quella complessa rete di sorveglianza ed avvistamento
costiero scandita lungo tutto il litorale salentino, dall’estremo confine
brindisino sull’adriatico a quello tarantino sullo ionio, dalle torri
litoranee.
Esse
hanno rappresentato da sempre una componente tradizionale nel panorama
delle coste del Salento e costituiscono oggi non solo una sempre più rara
(purtroppo) nota architettonica di pregio ed ambientale rilevantissima
ma sottolineano, nella loro regolare sequenza, l’antica sentita esigenza
di sicurezza collettiva da temuti nemici esterni provenienti dal mare,
cui inaridiva il cuore, non tocco da pietà cristiana, crudeltà corsara
ed odio barbaresco.
Tutto
il litorale perciò andò Yia via assumendo un aspetto fortificato attraverso
la realizzazione di veri e propri fortini localizzati in modo da dominare
gli approdi più probabili e ancor più i siti più prossimi a fonti d’acqua
e di approvvigionamento, integrandosi in una complessa rete di avvistamento
al fine di propagare l’allarme, in presenza di improvvise sortite di pirati
invasori, col maggiore anticipo possibile.
A
tracciarne la loro storia e ad individuarne i siti hanno egregiamente
contribuito, con saggi divenuti ormai dei classici, Onofrio Pasanisi e
Padre Primaldo Coco le cui informazioni Vittorio Faglia nel 1 978 ha
A
definire la mappa storica delle Torri litoranee perciò, nel filone dei
saggi citati, si vuole collocare questo nostro intervento alla luce di
un interessante documento proveniente dalle disperse carte StaianoPalmentola
di Gallipoli redatto certamente sulla scorta di documenti ufficiali allo
scopo forse di delineare una sorta di inventano degli approdi di mare
in relazione al servizio di sorveglianza marittima, di cui con estrema
precisione sono annotati personale e mezzi utilizzati, con definizione
dello stesso territorio di competenza.
Un
documento compilato certamente tra il 1 826 e la fine degli anni ‘30 sulla
scorta del «decreto organico
dell’Amministrazione de’ dazi indiretti de’ reali domini di qua del Faro»
del 1 3 Aprile 1 826 che stabiliva, con riferimento alla
legge organica del 10.12.1817, competenze proprie in ambito territoriale
del controllo doganale lungo i litorali al cui servizio erano state destinate
4 golette, scorridoje, castaudelle e gozzl.
L’art.
2 infatti ridefiniva la classificazione adottata con la legge del 1817
in 3 classi delle dogane, e riconfermava nella prima «di importazione, di esportazione e di cabotaggio» (con una riduzione a 14 luoghi contro i precedenti 26)
Taranto, Gallipoli e Brindisi, collocando nella seconda «di esportazione e cabotaggio» Otranto, ed infine nella terza «di cabotaggo» 5.
Cataldo e Porto di Villanova.
Che
nell’ambito dei controlli doganali le torri litoranee fossero state utilizzate
quali strutture logistiche è dato acquisito ed utilizzato soprattutto
dal Faglia sulla scorta di un inedito «Stato
delle torri Marittime» presso
l’Archivio di Stato cli Napoli che ci segnala al 1 842 34 torri ancora
in uso a tale scopo, 1 3 in abbandono, altre 1 3 andate distrutte e solo
2, quella di 5. Vito ceduta all’artiglieria e quella di Punta Rondinella
al Genio, destinate ad altro uso.
Il
nostro documento pertanto assume una importanza notevole non solo sotto
l’aspetto della documentazione circa l’organizzazione territoriale dei
controlli marittimi in Terra d’Otranto ma soprattutto perché costituisce
fonte di prima mano circa lo stato della loro conservazione strutturale,
dato ancor più rilevante se riferito, come nel caso delle torri del Fiume
e Tarantello, a strutture delle quali fino a ieri si era perduta anche
la memoria storica.
In
conclusione un elenco non sterile di 82 torri, delle quali ben 45 presidiate
o «armate» come
meglio è precisato, la cui sequenza lungo il litorale di Terra d’Otrando
scandiva a vista un controllo territoriale efficientissimo lungo il confine
marittimo non più tormentato per le crudeli scorrerie piratesche’ eppur
vigile sulle ampie distese di mare contro notturni clandestini sbarchi...
di contrabbandieri.
ELIO PINDINELLI